Mentre urlano le armi e civili inermi vengono aggrediti, costringendo uomini e donne alla fuga, noi cristiani e cristiane provenienti da diverse realtà ecclesiali, ci interroghiamo su come ogni chiesa possa contribuire alla pace.
La guerra è come una malattia allo stadio terminale, nei confronti della quale molte delle energie sono spese nel tentativo di arginarne i danni. Uno stadio terminale preparato da altri stadi. Nessuna guerra scoppia all'improvviso. Quando parlano le armi, i giochi ci appaiono già tutti fatti, sembra che ci siano pochissimi margini di intervento per fermare un conflitto armato.
Ma è proprio di fronte al dramma e al peccato della guerra che, come seguaci di Gesù Cristo, profeta «mite» e non violento (Mt 11,29), siamo chiamati a riscoprire la vocazione educativa al dialogo e alla pace per ricercare la sua giustizia.
Rinunciare a questa vocazione, ritenendola insufficiente se non secondaria rispetto all'emergenza, può significare la resa alla logica bellica. Siamo deboli, ma non impotenti! Dichiararci impotenti di fronte alla forza della violenza significa assecondare la logica della guerra e soccombere ad essa. La guerra non distrugge solo vite e città: invade anche le nostre anime, calpesta le libertà e paralizza la creatività nelle relazioni. La guerra che ci penetra dentro ci concede solo reazioni emotive, legate all'emergenza, ci tiene in ostaggio di una logica binaria che divide il mondo - e le chiese - in amici e nemici.
La vocazione delle chiese è certamente quella di farsi carico delle vittime, dei profughi; ma, insieme alla diakonia evangelica, lo specifico delle chiese ci spinge a lavorare ancor più intensamente per promuovere percorsi educativi di perdono e riconciliazione e occasioni di incontro tra soggetti differenti, a partire da quelle diversità ecclesiali contrapposte che lungo i secoli hanno insanguinato la nostra Europa e che il movimento ecumenico ha provato a fare incontrare e mettere in dialogo.
Se è vero che Giustizia e Pace appartengono al Signore e a Lui soltanto, è altresì vero che come uomini e donne credenti siamo chiamati a lavorare sulla terra e a seminare affinché l’umanità possa essere riconciliata e vivere la vocazione per la quale è stata creata.
L'ecumenismo ha messo in discussione la deriva imperialista e nazionalistica che, sia pure in misura e modalità diverse, tenta tutte le chiese; ha evidenziato il pericolo dell'autosufficienza che mina alla base le relazioni di comunione tra le chiese; è stato, e continua ad essere, un laboratorio di riconciliazione in cui scoprire la ricchezza delle tradizioni cristiane plurali. All'interno degli inevitabili conflitti e dei diversi punti di vista, il Sae richiama la logica della differenza evangelica che Gesù ha mostrato ai suoi discepoli: “tra voi non sia così” (Mc 10,43).
Sulla base di questa vocazione ci mettiamo in preghiera. Preghiamo perché tacciano le armi cessi l'odio e l'indifferenza e si avvii un processo di pace che conduca a una piena riconciliazione.
Mentre preghiamo, ci lasciamo educare dalla sapienza paradossale della preghiera stessa così che Dio intervenga all'interno dei nostri conflitti e ci educhi ad accogliere e ad amare anche il nemico. Insieme alla preghiera, ci impegniamo a tenere aperte le occasioni di incontro e di confronto tra chiese sorelle, in modo tale che i diversi punti di vista possano essere esplicitati e affrontati con creatività evangelica.
L'impegno per la pace domanda tutta la nostra intelligenza, tutte le nostre forze e una incessante conversione del cuore. Continuiamo a lavorare affinché tutte le chiese osino la pace per fede: riconoscendosi nell’Eucarestia come Corpo di Cristo, ogni singola comunità cristiana diventi scuola di nonviolenza affinché quest’unico corpo storico non sia più diviso ma sempre più corpo di pace, lievito di fraternità per la famiglia umana e luce di speranza per il mondo.
Gruppo Teologico del SAE

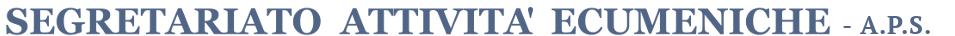
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE