Come ogni gennaio, allo schiudersi dei nuovi chiarori dell’anno si riaccende anche la luce della preghiera per l’unità dei cristiani. Un appuntamento cui non possiamo mancare, un segno che non deve venir meno: segno di invocazione e di speranza, di attesa e di consolazione, di povertà e di riconoscenza, attraverso cui anche sul presente più travagliato e desolato giunge un raggio della promessa e del futuro di Dio.
Ma, perché questo avvenga, bisogna che la Settimana di preghiera non scada in un rituale d’obbligo, in una pratica cerimoniale di routine, mantenuta in forme esterne anche solenni ma internamente avvizzita, stancamente ripetitiva, alibi illusorio di un disimpegno reale. Questo rischio c’è, lo avvertiamo chiaramente, in noi e nelle nostre chiese, e a scongiurarlo si richiedono vigilanza e accensione spirituale.
La preghiera per l’unità, come ogni vera preghiera, è un rivolgersi a Dio che impegna radicalmente la persona e la comunità oranti; è un’invocazione e un’attesa dello Spirito creatore e ricreatore, ma che si compie nell’atto stesso in cui si alza la vela per accoglierne il soffio e lasciarsi sospingere oltre; è un abbandono e uno spossessamento di sé, ma per ricevere chiarezza di sguardo e libertà di movimento sulle nuove strade che Dio ci apre. La celebrazione della Settimana ha dunque senso se, mentre si ringrazia Dio per la comunione di cui ci fa dono e lo si implora di farla crescere in noi e tra noi, ci si dispone a riconoscerla e viverla nel dipanarsi del tempo, nel susseguirsi degli incontri e delle esperienze, nella dimensione interiore della vita come nelle relazioni personali e comunitarie. Se, insomma, essa è veramente preghiera, cioè luce vitale e forza trasformatrice.
Proprio in questo senso ci orienta il tema della Settimana di quest’anno: «Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore».
Un annuncio di rigenerazione e di vittoria, ma che nel contesto della prima lettera ai Corinzi, da cui è tratto, è posto in stretta relazione con un processo di spogliazione e di morte. Qualcosa deve morire perché vi sia risurrezione, qualcosa deve dissolversi perché la vita e la realtà siano trasformate. L’immagine simbolica che ne dà chiara idea è nella lettera di Paolo, come nel Vangelo di Giovanni, quella del seme, del chicco di grano che si sfa perché dalla sua morte nasca la nuova vita. La vittoria di Gesù Cristo, e la nostra trasformazione che ne consegue, si realizzano attraverso questo passaggio cruciale.
Che cosa dovrà dunque morire in noi, nelle nostre chiese, perché si compia ciò che invochiamo nella preghiera? Di quali rigidi gusci dobbiamo essere disposti a svestirci, perché possa svilupparsi la fecondità del seme? Non so e non voglio dare risposta precisa a queste domande; preferisco lasciarle aperte, perché ciò che innanzi tutto importa è lasciarsene investire, cioè la consapevolezza e l’accettazione di questo necessario processo di spogliazione e purificazione, a cui penserà Dio stesso a dare contenuto e forma giorno dopo giorni, se noi e le nostre chiese sapremo allentare la guardia gelosa delle nostre pretese e presunzioni per lasciarci modellare dalle sue mani. Noi e le nostre chiese, ciascuno e ciascuna per la propria parte, resistendo alla ricorrente e insidiosa tentazione – dalla quale nessuno e nessuna è esente – di pensare e volere che siano prima di tutto e soprattutto gli altri e le altre a dover convertire il proprio cammino. L’appello alla conversione non ci viene mai rivolto per altri, ma per noi stessi.
L’immagine del seme, infine, ci dice un’altra cosa. Il germoglio che nasce dal suo disfacimento è una vita nuova, ma non radicalmente «altra» da quella condensatasi nel seme: è la stessa, ma tornata alla sua originaria freschezza e capacità di futuro, e in questo futuro si riversa e si rinnova tutta la ricchezza accumulata nel passato. Secondo il detto di Gesù, si tratta di una «perdita» della propria vita che in realtà la «salva». La «vittoria» del Risorto, dice ancora l’apostolo, ha «ingoiato», «sommerso» la morte. È nella luce delle Risurrezione che noi e le nostre chiese preghiamo d’essere «trasformati».
Pongo qui termine al mio discorso per lasciare spazio alla parola di un amico e maestro dal quale tanto abbiamo ricevuto e che sentiamo ancora presente e vivo in noi e tra noi, a venticinque anni dalla sua morte (anch’essa, potremmo dire, una morte per la vita): Germano Pattaro. In pagine spiritualmente vibranti dedicate alla preghiera ecumenica egli scrive che in essa «i cristiani esprimono il “sì” della vocazione all’unità, che diventa imperativo di grazia e di fedeltà […]. Si sottraggono a loro stessi, escono dagli interessi di parte ed entrano nello spazio vero dell’unica chiamata. Si decidono, di conseguenza, per Dio e si lasciano mettere da parte a favore del servizio d’amore a cui Dio li destina. Con Dio e in Dio confessano di non appartenersi e di essere donati gli uni agli altri in maniera vincolante, senza eccezioni e senza alibi. La preghiera per l’unità diviene, allora, il movimento che concentra i cristiani in questa consapevolezza vocativa, che ritorna continuamente alla sua sorgente e da essa parte per il mandato ricevuto. Senza che mai si rompa la continuità che porta il discepolo a Dio e, in Dio, ai fratelli, nella doppia relazione di un percorso mai spezzato. Per questo è detto che la preghiera per l’unità è possibile perché, in Cristo e a causa di Lui, essa è, nello Spirito che geme nel cuore dei cristiani , l’unità stessa che diviene preghiera. Unità da ultimarsi, ma già realtà di comunione che li fa essere “fratelli”».
(c) 2014 Your Copyright Info
A Joomla51.com Design

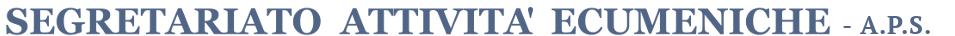
 DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE SESSIONI DI FORMAZIONE
SESSIONI DI FORMAZIONE